Traduzione del testo scritto da Wentworth a cura di Kiara, tratto da una nota revisionata del discorso dell’evento di Seattle HRC 2013, condivisa da Went su Facebook un anno dopo il coming out.
_____________________________________________________________________________________________
Grazie. Vorrei prima di tutto ringraziare personalmente la Human Rights Campaign per il lavoro incredibile che ha fatto e che continua a fare. Non solo nello stato di Washington, ma per tutto il Paese. E nel mondo. Sappiamo che questo lavoro è fondamentale. Può cambiare delle vite. Può salvarle.
E’ un grande onore per me e un privilegio essere qui stasera, come un membro di questa comunità. E’ anche una sorta di sorpresa.
Ho avuto un rapporto complicato con quella parola: “Comunità”.
Ho avuto bisogno di molto tempo per accettarla. Sono stato esitante. Sono stato dubbioso.
Per molti anni non ho potuto – o non ho voluto – accettare che ci fosse qualcosa in quella parola per qualcuno come me. Come “legame”. O “sostegno”. O “forza”. O “calore”.
E ci sono varie motivazioni per questo.
Non sono nato in questo Paese, non sono cresciuto con dei valori religiosi in particolare, ho una origini razziali miste, e sono gay. E’ la tipica storia di un ragazzo della porta accanto Americano.
Ed è stato normale per me vedermi come un singolo individuo, la sfida è stata riuscire ad immaginarsi parte di qualcosa di più grande.
Come molti di voi qui stasera, sono cresciuto in quel che chiamerei “modalità di sopravvivenza”.
Quando sei in “modalità di sopravvivenza”, il tuo obiettivo diventa arrivare a fine giornata intero. E se sei in quello stato a 5 anni… a 10… a 15… non c’è molto spazio per parole come comunità. Parole come “nostro” e “noi” C’è solo spazio per l'”IO” e “ME” .
Infatti, parole come “nostro” e “noi” non solo mi suonavano come sconosciute a 5… e a 10… e a 15 anni… mi suonavano come bugie. Perché se davvero fosse esistito un “noi”, se ci fosse stato davvero qualcuno al di fuori ad osservare, ad ascoltare e a cui fosse importato, sarei stato messo in salvo.
Quella sensazione di essere unico, diverso e solo l’ho portata con me fino ai miei 20 anni. E fino ai 30. A 33 anni ho iniziato a lavorare per uno show televisivo, che è stato un successo non solo qui negli States ma anche nel resto del mondo. Cosa che mi ha portato nei successivi 4 anni a viaggiare in Asia, Medio Oriente, Europa e qualunque altro posto nel mezzo.
E a quel tempo ho rilasciato migliaia di interviste. Ho avuto moltissime occasioni di dire la verità. Ovvero che ero gay. Ma ho scelto di non farlo. L’avevo confessato privatamente – alla mia famiglia e agli amici – e a gente di cui mi sono fidato nel tempo. Ma professionalmente, pubblicamente non lo ero. Dovendo scegliere tra tradire la mia integrità o uscire fuori dal mio nascondiglio, ho scelto la prima opzione. Ho scelto di mentire. Ho scelto di nascondermi.
Perché quando ho pensato alla possibilità di dichiararmi, di come avrebbe avuto un impatto su di me e sulla mia carriera per cui avevo tanto lavorato, sono stato preso dal panico. Dal panico e dalla rabbia. E dalla tenacia a resistere che ho costrutito nel corso di molti anni.
Quando ho pensato a quel ragazzino lì fuori da qualche parte, che si sarevve sentito ispirato o commosso dalla mia presa di posizione e dalla mia scelta di dire la verità, la mia risposta mentale è stata – sostanzialmente – “No grazie”. Ho pensato “Ho speso oltre dieci anni per costruirmi questa carriera, da solo, con le mie forze. E ora dovrei mettere tutto a rischio? Per essere un modello da seguire? Per qualcuno che non ho mai incontrato? E che non sono neanche sicuro che esista?”. Non aveva molto senso per me. Non aveva alcuna logica. A quel tempo.
Come per molti di voi qui stasera, crescendo sono stato un bersaglio. Parlare nel modo giusto, star in piedi nel modo giusto, tenere il polso nel modo giusto. Ogni giorno era un test e c’erano mille modi per sbagliare. Mille modi per tradirti. Per non essere all’altezza degli standard di qualcun altro di quello che era accettabile. Di quello che era “normale”. E quando fallivi il test – cosa praticamente garantita – c’è un prezzo da pagare. Emozionalmente. Psicologicamente. Fisicamente. E come molti di voi, ho pagato anche io quel prezzo. Più di una volta. In diverse maniere.
La prima volta che ho provato a suicidarmi, avevo 15 anni.
Ho aspettato che la mia famiglia andasse fuori per il weekend e che rimanessi solo in casa, e ho ingoiato un contenitore intero di pillole.
Non ricordo cos’è successo nei due giorni successivi, ma sono abbastanza sicuro che il Lunedì mattina, fossi sul bus per tornare a scuola, facendo finta che tutto andasse bene. E quando qualcuno mi chiede se è stato un “grido d’aiuto”, rispondo di “no”. Perché non l’avevo detto a nessuno. Cerchi aiuto solo se c’è un aiuto per cui gridare. E non l’ho fatto. Volevo venirne fuori. Volevo farla finita. A 15 anni.
“Io” e “me” possono essere un posto solitario. E questo ti porterà solo lontano.
Ma nel 2011 ho preso la decisione di smettere di recitare, e di lasciare molte di quelle cose che pensavo fossero importanti per me. E dopo aver smesso con gli script e con i set (che ho sempre sognato da bambino), con le risultanti attenzioni morbose (che NON sognavo da bambino), l’unica cosa con cui avevo realmente lasciato era quello che avevo quando avevo iniziato..l'”IO” e il “ME”. Ma non era abbastanza.
Nel 2012 ho iniziato a frequentare un gruppo chiamato The ManKind Project – un gruppo di uomini per tutti gli uomini – e mi ha introdotto a quei concetti ancora sconosciuti e potenzialmente minacciosi di “nostro” e “noi”. All’idea di “fratellanza”, “sorellanza” e “comunità”. Ed è stato attraverso questa comunità che sono divenuto un membro e un orgoglioso sostenitore della Human Rights Compaign. Ed è stato attraverso questa comunità che ho imparato di più sulla persecuzione dei miei amici e sorelle della comunità LGBT in Russia.
Qualche settimana fa, quando stavo scrivendo la mia lettera al Festival Internazionale del Cinema di San Pietroburgo, declinando il loro invito a partecipare, una fievole, assillante voce nella mia testa insisteva nel dire che nessuno l’avrebbe notato. Nessuno stava osservando, ascoltando o se ne preoccupava. Ma questa volta, finalmente, sapevo che quella voce si sbagliava.
Ho pensato, “Anche se una sola persona lo noterà, questa lettera – nella quale dico la verità e aggiungo la mia piccola storia ad una molto più grande e importante – vale la pena che sia spediata”. Ho pensato “Fatemi essere qualcun’altro, quel qualcuno che nessuno è stato per me. Fatemi mandare un messaggio a quel bambino – forse in America o forse in qualche posto lontano oltre gli oceani, forse da qualche parte nel profondo, un ragazzino che può essere stato preso di mira a casa, a scuola, per la strada, quel qualcuno sta osservando, ascoltando e se ne preoccupa. In quello c’è un “nostro”. In quello c’è un “noi”. E quel bambino o adolescente o adulto è amato. E non sono soli.
Sono profondamente grato alla Human Rights Compaign per aver dato a me e altri come me l’opportunità, la base e l’imperativo di di condividere la nostra storia e di continuare a mandare quel messaggio. Perché c’è bisogno che venga mandato. Ancora ed ancora. Finché non è stato ascoltato, ricevuto e fatto proprio.
Non solo qui nello stato di Washington. Non solo in giro nel Paese. Ma nel mondo intero. E poi ricominciare di nuovo. Solo in caso. Solo in caso avessimo dimenticato qualcuno.
Grazie.
_____________________________________________________________________________________________
Il testo riportato qui sotto in lingua originale è stato condiviso da Wentworth, su facebook, il 13 giugno 2014, caricato in una nota intitolata “HRC Gala / Remarks / Seattle, WA / September 2013”
Thank you. First and foremost, I want to personally thank the Human Rights Campaign for the incredible work they have done and the work they continue to do.
Not only here in Washington State, but across the country. And around the world. As we all know this work is critical. It’s life-changing. And it’s life-saving.
It is my great honor and privilege to be here tonight, to count myself a member of this community.
It is also something of a surprise.
I’ve had a complicated relationship with that word. “Community.” I’ve been slow to embrace to it. I’ve been hesitant. I’ve been doubtful.
For many years I could not – or would not – accept that there was anything in that word for someone like me. Like connection. Or support. Or strength. Or warmth.
And there are reasons for that.
I wasn’t born in this country, I didn’t grow up in any one particular religion, I have a mixed-race background….and I’m gay.
Really just you’re average, all-American boy-next-door.
It’s been natural to see myself as an individual. It’s been a challenge to imagine that self as part of something larger.
Like many of you here tonight, I grew up in what I would call “survival mode.”
When you’re in survival mode, your focus is on getting through the day in one piece. And when you’re in that mode at 5… at 10… at 15… there isn’t a lot of space for words like “community.” For words like “us” and “we.” There is only space for “I” and “me.”
In fact, words like “us” and “we” not only sounded foreign to me at 5… and 10… and 15… they sounded like a lie. Because if “us” and “we” really existed, if there was really someone out there watching and listening and caring, then I would’ve been rescued by now.
That feeling of being singular and different and alone carried over into my 20s. And into my 30s. When I was 33, I started working on a TV show that was successful not only here in the States but also abroad. Which meant over the next four years I was traveling to Asia, the Middle East, to Europe, and everywhere in between.
And in that time I gave thousands of interviews. I had multiple opportunities to speak my truth. Which is that I was gay. But I chose not to. I was out privately – to family and friends – to the people I’d learned to trust over time. But professionally, publicly, I was not. Asked to choose between being out of integrity and out of the closet, I chose the former. I chose to lie. I chose to dissemble.
Because when I thought about possibility coming out, about how that might impact me and the career I’d worked so hard for, I was filled with fear. Fear and anger. And a stubborn resistance that had built up over many years.
When I thought about that kid somewhere out there, who might be inspired or moved by me taking a stand and speaking my truth, my mental response was – consistently – “No thank you.” I thought, “I’ve spent over a decade building this career. Alone. By myself. And now I’m supposed to put that at risk? To be a role model? To someone I’ve never met? Who I’m not even sure exists?” That didn’t make any sense to me. That didn’t resonate. At the time.
Also like many of you here tonight, growing up I was a target. Speaking the right way. Standing the right way. Holding your wrist the right way. Every day was a test. And there were a thousand ways to fail. A thousand ways to betray yourself. To not live up to someone else’s standard of what was acceptable. Of what was “normal.” And when you failed the test – which was guaranteed – there was a price to pay. Emotional. Psychological. Physical. Like many of you I paid that price. More than once. In a variety of ways.
The first time I tried to kill myself I was 15. I waited until my family went away for the weekend and I was alone in the house, and then I swallowed a bottle of pills.
I don’t remember what happened over the next couple of days, but I’m pretty sure come Monday morning I was on the bus back to school, pretending like everything was fine. And when someone asks me if that was a “cry for help” I say “no.” Because I told no one. You only cry for help if you believe there’s help to cry for. And I didn’t. I wanted out. I wanted gone. At 15.
“I” and “me” can be a lonely place. And it will only get you so far.
By 2011 I’d made the decision to walk away from acting and many of the things I’d previously believed to be so important. And after I’d given up the scripts and the sets (which I’d dreamed of as a child), and the resulting attention and scrutiny (which I had not dreamed of as a child), the only thing I was left with was what I had when I started – “I” and “me.” And it was not enough.
In 2012 I joined a men’s group called The ManKind Project – a men’s group for all men – and was introduced to the still foreign and still potentially threatening concepts of “us” and “we.” To the idea of “brotherhood,” “sisterhood,” and “community.” It was via that community that I became a member and proud supporter of the Human Rights Campaign. And it was via this community that I learned more about the persecution of my LGBT brothers and sisters in Russia.
Several weeks ago, when I was drafting my letter to the St. Petersburg International Film Festival, declining their invitation to attend, a small, nagging voice in my head insisted that no one would notice. That no one was watching or listening or caring. But this time, finally, I knew that voice was wrong.
I thought, “If even one person notices, this letter – in which I speak my truth and integrate my small story into a much larger and more important one – is worth sending. I thought, “Let me be to someone else what no one was to me.
Let me send a message to that kid – maybe in America, maybe someplace far overseas, or maybe somewhere deep inside, a kid who’s being targeted at home or at school or in the streets, that someone is watching and listening and caring. That there is an ‘us.’ That there is a ‘we.’ And that kid or teenager or adult is loved. And they are not alone.”
I am deeply grateful to The Human Rights Campaign for giving me and other like me the opportunity and the platform and the imperative to tell my story and to continue sending that message. Because it needs to be sent. Over and over again. Until it’s been heard and received and embraced.
Not just here in Washington State. Not just across the country. But around the world. And then back again. Just in case. Just in case we missed someone.
Thank you.
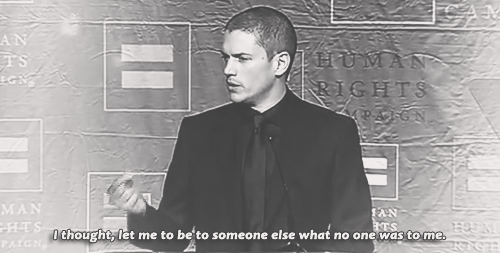


la prima cosa che ho sentito di Went.
Il momento in cui ho cominciato ad amarlo!